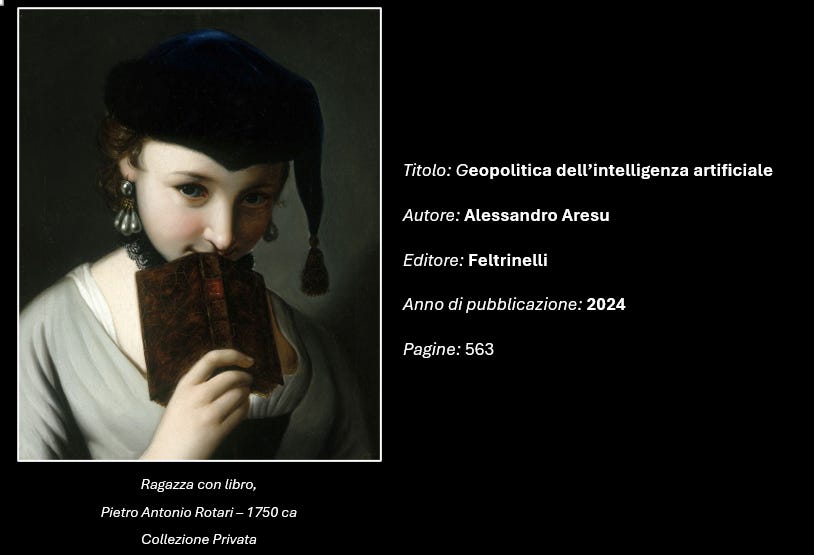LEGGER(MENTE) – LE RECENSIONI DI BLAST – Geopolitica dell’intelligenza artificiale
di Chiara Forino
L’intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti, ogni giorno. In rete, come nei “salotti buoni”, si dibatte dell’impatto e delle opportunità della quarta rivoluzione industriale, ma anche dei rischi economici e dei dilemmi etici cui una tecnologia così potente e pervasiva espone le nostre vite già oggi e, ancora di più, in un futuro sempre più complesso e imprevedibile.
Questa tecnologia, però, non è arrivata dall’oggi al domani. È il frutto di decenni di studi, ricerche, scelte politiche e scientifiche che si sono avvicendate e intrecciate in tutto il globo terracqueo. Per capirla meglio, e non esserne travolti, oggi propongo l’ultima opera di Alessandro Aresu, che racconta il complesso arazzo del mondo racchiuso nelle due semplici parole “Intelligenza Artificiale”. Con uno stile scorrevole e rigoroso, Aresu raccoglie i mille dettagli in cui individuale e collettivo si intrecciano e dove, come nella trama dei migliori film d’azione, storie personali, scelte governative, approcci culturali, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, si incastrano, per provare a comprendere come si è arrivati ai giorni nostri in un percorso in continua e rapidissima evoluzione.
Buona lettura!
In origine, l’intelligenza artificiale è stata un’operazione di marketing. E, scavando nella storia, tutto ha avuto origine dalla caparbia passione per i videogame di un giovane immigrato che, spedito a dieci anni in Kentucky, trascorre l’infanzia in un riformatorio (senza aver commesso alcun reato). Questi due piccoli aneddoti danno l’idea dell’approccio con cui è stato scritto questo atlante della tecnologia che sta travolgendo le economie di tutto il mondo.
Non un racconto lineare incentrato (solo) sullo sviluppo tecnologico di software e hardware, ma una raccolta di date, persone, imprese e fatti che, in un volo pindarico tra spazio e tempo, consente a chi legge di mettere insieme, un capitolo dopo l’altro, le tessere di un intricato mosaico con più personaggi di un romanzo russo.
Quando è nata l’idea dell’intelligenza artificiale? Come si è passati dal “Turco Meccanico” che nel XVIII secolo ha affascinato (e ingannato) l’Europa all’“intelligenza artificiale artificiale” (ripetuto due volte) che sfida quotidianamente i limiti dello sviluppo tecnologico? E ancora, cosa c’entrano un poeta come Leopardi o un filosofo-matematico come Liebniz con la geopolitica dell’intelligenza artificiale?
A questa e a molte altre domande e curiosità risponde questa monumentale opera di Aresu, filosofo e Consigliere per gli Affari Strategici al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale che, usando come filo conduttore la vita e le opere di Jen-Hsun (Jensen) Huang, il fondatore e volto pubblico del gigante Nvidia, ci accompagna in un viaggio che attraversa i secoli e i confini nazionali per tessere le interrelazioni tra le discipline che hanno giocato e stanno giocando un ruolo nella sfida tecnologica del millennio, dalla programmazione all’economia, dalla finanza alla psicologia, dall’antropologia alla fisica, dalla filosofia all’etica, senza dimenticare il fantasy e i videogiochi.
Capacità di calcolo, semiconduttori, database fanno da sfondo alla narrazione che, pagina dopo pagina, racconta la guerra tecnologica e commerciale combattuta da decenni a suon di dazi, divieti e sanzioni (che hanno perso il loro potere deterrente, incapaci di tenere il passo agli enormi guadagni delle aziende che vorrebbero regolamentar). Si delinea l’evoluzione del lavoro e il diverso approccio alle relazioni industriali che spiega, almeno in parte, la capacità della Cina e dei Paesi orientali di raggiungere obiettivi che per l’Occidente iper-normato e iper-tutelato sembrano irraggiungibili, nonostante (o grazie) al “vantaggio dell’arretratezza” di cui gode una delle più grandi potenze manifatturiere del mondo.
Racconta di supply chain interconnesse e transnazionali, che devono costantemente reinventarsi un equilibrio tra America e Oriente, tra esigenze economiche e leggi che asseriscono di tutelare la sicurezza nazionale. Lo sviluppo delle grandi aziende che costituiscono la linfa vitale dell’intelligenza artificiale, dai nomi più noti di OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, Meta ai colossi sconosciuti di DeepMind, Synospsis, Mellanox, TSMC passa da investimenti, statali e privati, che hanno investito cifre a nove zeri senza, ad oggi, un reale profitto, con una crescita esponenziale di cui è difficile comprendere la sostenbilità. E che pone quesiti di carattere economico, ma anche etico e ambientale, con un consumo di suolo e di risorse che, inevitabilmente, crea ricchezza per pochi e sfruttamento e disagi per molti. Dai “vantaggi per l’umanità” perseguiti (almeno sulla carta) da OpenAI alla “disoccupazione tecnologica” codificata da Keynes all’inizio del XX secolo, l’autore tratteggia i possibili scenari, più o meno distopici, di una tecnologia che minaccia di prendere il controllo sull’umanità. Ne descrive le leggi, da Moore a Huang, che provano a prevedere l’imprevedibile rapidità evolutiva di una tecnologia che ha saputo nascere dalla fantascienza di Tolkien, dalla volontà di riscatto di tanti giovani immigrati, dai gattini del programma ImageNet di Fei-Fei-Li e dalla curiosità, quella ancora esclusivamente umana, di andare sempre oltre i limiti conosciuti, di vincere nuove sfide e, in definitiva, di creare una realtà mai immaginata prima.
Perché leggerlo: Perché l’intelligenza artificiale è un tema che, per essere compreso, richiede non solo di uscire dagli schemi semplicistici della mera tecnologia e dal punto di vista “occidentocentrico”, ma di riconoscere il ruolo crescente di economie fino a ieri considerate principalmente manifatturiere e in evoluzione, come Cina e India, e, soprattutto di abbracciare la complessità di un processo multidisciplinare e globale, dove informatica e tecnologia si intrecciano indissolubilmente con economia e le decisioni politiche, con le aspirazioni di singoli individui e le scelte strategiche di aziende con il peso politico di stati, in un ordito affascinante di scienza e tecnologia, potere ed etica, filosofia ed economia di cui ognuno può scegliere l’area di maggior interesse senza perdere la visione globale.
Lascia perdere se: non ami i “mattoni” ricchi di tecnicismi e di riferimenti interdisciplinari, che non seguono una linea temporale o un filo logico sequenziale. L’autore, pur con un approccio scientificamente rigoroso, ha scelto una narrazione episodica, che, ex-post, ha perfettamente senso, ma in itinere risulta a tratti disorientante per chi non è abituato a salti logici e temporali. Pur presentando, in appendice, una cronologia essenziale e una rubrica dei personaggi principali, infatti, può risultare dispersivo a una prima lettura. Soprattutto, non leggerlo se non vuoi sentire, dati alla mano, le amare conclusioni sull’Europa, auto-relegata a affannato normatore di un mondo che sembra non essere in grado di capire (con poche eccezioni).